“La distruzione di una comunità politica, la fine della democrazia è sempre possibile… e oggi come allora gli avversari della democrazia stanno anche dentro di noi, nel perenne conflitto, ch’è a un tempo sociale e psichico, tra bisogno di sicurezza e desiderio di libertà.” (Luciano Gallino).
Questa è la storia di una piccola città della Germania durante gli anni della Repubblica di Weimar e i primi anni del Terzo Reich; ed è al contempo un tentativo di comprendere come una democrazia civile sia potuta precipitare e affondare in una dittatura. Thalburg (in realtà Nordheim) è un tranquillo centro dell’antico regno dello Hannover, diecimila abitanti, molto commercio e poche industrie, che negli anni che vanno dal 1930 al 1935, come tutta la Germania, cambia volto: sulla base di una documentazione e di un’indagine personale, Allen racconta le tappe di quella tragica trasformazione, dando un volto e un’identità precisa a fatti e persone che hanno legato il loro destino alle sorti del popolo tedesco.
Titolo: Come si diventa nazisti.
Autore: William Sheridan Allen.
Genere: Saggio.
Editore: Einaudi.
Prezzo: euro 12,00 (copertina flessibile).
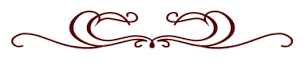
Thalburg (in realtà Nordheim, nello Hannover) è una ridente cittadina. Diecimila abitanti, attività commerciali, un po’ di industria. Tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, vi si svolge una lotta silenziosa e feroce, che ha come posta -senza che i solerti cittadini se ne rendano conto- la democrazia.
Una lotta analoga si svolge in tutta la Germania, anche se gli storici hanno preferito studiare le mosse di ministri e cancellieri, sindacati, grandi industriali e militari. La piccola Thalburg/Nordheim è rimasta fuori da quell’attento, instancabile lavoro di ricerca e analisi.
Allen, invece, studia la gente comune: gli impiegati del Municipio, i reduci della Grande Guerra tornati nella cittadina natale, gli operai della ferrovia e i giornalisti del piccolo quotidiano locale. Si analizzano le librerie, il Club dei Giardinieri, la Società di Mutuo Soccorso fra i lavoratori, il Consiglio Comunale, le minuscole sedi di qualche sindacato/partito.
Trent’anni dopo gli avvenimenti che mutano profondamente questa cittadina, Allen scrive il suo libro (***). È trascorso del tempo, ma molti degli attori di quei giorni sono ancora vivi e possono parlare con lo storico. Così come sono disponibili le raccolte del quotidiano locale, gli atti del Municipio. I luoghi stessi, non toccati dai bombardamenti, sono un libro aperto da leggere e capire.
Quando Allen comincia a raccontare piccoli episodi, spesso futili, di scarsissima importanza, o semplicemente irritanti per il senso comune, non ci accorgiamo di dove stiamo andando, noi e i cittadini. Lo capiamo solo alla fine, quando quegli episodi -messi in fila, uno dopo l’altro- hanno già contribuito a creare un destino tragico e cruento.
Allora, torniamo indietro, come Pollicini alla ricerca dei piccoli sassi che dovrebbero insegnarci la strada. E cominciamo ad analizzare, per esempio, i risultati delle elezioni. Chi vota a Thalburg? La borghesia e i lavoratori. I voti dei lavoratori vanno sostanzialmente a tre partiti: il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi (NSDAP), alle elezioni del 1928 ottiene 123 voti. Pochi suffragi anche per il Partito Comunista. Il Partito Socialista di Germania (SPD) ottiene 2200 voti (in tutto, i voti sono 5400, in tutto il territorio comunale). Quelli della borghesia si disperdono in una miriade di piccoli partiti; solo il Partito dello Stato ottiene 500 voti.
In due anni, i voti per la NSDAP aumentano di quattordici volte: da 123 a 1742, su un totale di 6000 voti circa. Ancora due anni, e i voti diventano 4200. Per poi diventare una valanga nel 1933.
Libere elezioni.
Libera scelta dei cittadini.
Non ci fu un colpo di Stato, non ci fu un’invasione di nemici.
Nessuno consegnò la cittadina al nazismo.
Furono i cittadini.
Dopo, avvenne il colpo di Stato, quando la strada era stata già preparata.
Che cosa era successo, a Thalburg e nell’intera Germania?
La situazione economica era difficile. Anche se la disoccupazione nella cittadina non superava il 15% della forza-lavoro, erano ben visibili le file di disperati che si allungavano davanti all’Ufficio Distrettuale di Collocamento, di cui Thalburg era la sede. La crisi colpiva il piccolo commercio e molti negozi erano costretti a chiudere; le ridotte risorse economiche facevano sì che meno alunni frequentassero le due scuole secondarie. Ovunque, aleggiava una condizione psicologica di insicurezza e di sfiducia nell’avvenire.
Il trattato di Versailles aveva ferito aspramente tutti i cittadini tedeschi, senza distinzione, e gli abitanti di Thalburg non facevano eccezione. Il sentimento di umiliazione faceva sì che molti guardassero con disprezzo a quella classe politica che si era piegata e aveva firmato il trattato di pace.
Paure reali e irreali: su questo fecero leva i nazisti presenti nella cittadina. Le promesse in campo economico, politico e sociale riuscirono a lenire l’angoscia di tutti. E seppero ispirare un profondo senso di sicurezza in una massa incerta e bisognosa di rassicurazione.
Ponendosi come scudo contro il comunismo, i nazisti seppero catturare l’appoggio della borghesia imprenditoriale e industriale.
Rifiutando i termini del Trattato di Versailles, riuscirono a convincere gli elettori che avrebbero combattuto per riscattare l’onore e l’orgoglio tedeschi.
 Gli altri partiti presenti a Thalburg non seppero opporsi con una politica comune all’avanzata del nazismo. E il risultato finale -per Thalburg e per la Germania- l’abbiamo studiato sui libri di storia.
Gli altri partiti presenti a Thalburg non seppero opporsi con una politica comune all’avanzata del nazismo. E il risultato finale -per Thalburg e per la Germania- l’abbiamo studiato sui libri di storia.
Tornando alla nostra cittadina, in essa accadde quanto si andava sviluppando in tutto il Paese. Nel giro di pochissimo tempo, tutto un sistema politico-sociale fu distrutto e riedificato. La comunità di Thalburg cessò di esistere così come l’avevano costruita nei secoli i suoi cittadini.
Allen avvisa il lettore che Thalburg non è rappresentativa di tutta la Germania, è onesto in questa precisazione. Però, ciò che lo storico ci presenta è una conoscenza che supera quel luogo -Thalburg- e quel tempo -gli anni Venti/Trenta- e che ci porta a riflettere: esiste qualcosa in grado di far sì che quanto accaduto in quel luogo e in quel tempo non si ripresenti di nuovo in qualche area del nostro mondo?
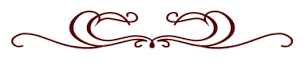
William Sheridan Allen (Evanston 1932 – Buffalo 2013), dopo gli studi all’Università del Minnesota, alla Libera Università di Berlino e a quella di Göttingen, ha insegnato presso l’Università di Buffalo, nello Stato di New York.
(***) “Come si diventa nazisti”, fu pubblicato da Einaudi nel 1968. Viene ora riproposto in edizione tascabile.
Copia acquistata.






Commenti recenti